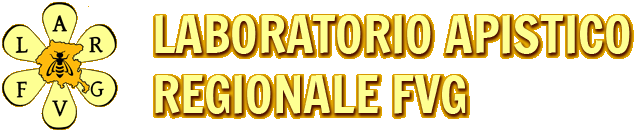Premessa
L’emergenza sanitaria in corso ha costretto tutti noi a stare a casa e limitare gli spostamenti allo stretto necessario.
Fortunatamente, l’attività apistica è stata fra le poche risparmiate dalle restrizioni imposte dal Governo e, con le dovute autorizzazioni, gli apicoltori hanno potuto raggiungere i propri apiari e visitare le colonie. Questo privilegio, negato alla maggior parte delle persone, ha permesso agli apicoltori di apprezzare ancora una volta il lavoro che svolgono con passione e dedizione.
L’occasione, però, è utile per fare alcune considerazioni sui virus e proporre interessanti analogie fra quelli che infettano l’uomo e quelli che colpiscono le api, per sfruttare quanto abbiamo appreso su Covid-19 dai mezzi di comunicazione, al fine di comprendere più a fondo un temibile avversario delle nostre api e contemporaneamente affrontare con maggiore consapevolezza l’emergenza che dobbiamo fronteggiare.
I virus delle api
Come noto, le api possono essere infettate da numerosi agenti patogeni. Fra questi, i virus sono sempre stati poco considerati dagli apicoltori. Essi, infatti, sono invisibili a occhio nudo e, nella maggior parte dei casi, causano sintomi poco definiti e di difficile interpretazione.
In effetti, qualche tempo fa, un apicoltore non privo di istruzione ed esperienza arrivò perfino ad accusarci di sopravvalutazione del problema virus. Peccato che già allora i dati riguardanti il ruolo centrale dei virus nei collassi delle colonie lasciavano poco spazio alle interpretazioni e si stava facendo strada la teoria secondo cui il Virus delle Ali Deformi (DWV) rappresenta, in pratica, la spada di Damocle che incombe sui nostri alveari. Una spada sospesa all’esile filo delle difese innate dell’ape, che però possono essere perturbate da vari fattori, come l’acaro parassita Varroa destructor, certi insetticidi e la carenza di alimentazione di qualità.
Tuttavia, la Varroa si vede bene a occhio nudo e i pesticidi sono ben noti a qualunque apicoltore, non foss’altro perché quasi tutti sono costretti a usarli dentro i propri alveari contro l’acaro. Invece, per vedere il Virus delle Ali Deformi serve almeno un microscopio elettronico e per deformare le ali di una povera ape rendendo visibile l’infezione, servono qualcosa come un milione di miliardi di particelle virali. Perciò, una certa ignoranza del problema virus è comprensibile e forse è arrivato il momento di colmare queste lacune.
A oggi, sono stati descritti più di venti virus diversi che attaccano le api e gli apoidei in generale e alcuni di essi sono estremamente pericolosi per questi insetti.
Struttura
La maggior parte dei virus delle api possiede un genoma semplice, costituito da un singolo filamento di RNA, rivestito da un capside proteico.
Questa struttura implica che appena il virus riesce ad attaccarsi alle cellule dell’ospite, il filamento di RNA penetra all’interno, dove prende il controllo della “fabbrica delle proteine”, che da quel momento inizia a produrre copie del virus. Quando la cellula è letteralmente zeppa di virus, esplode riversando all’esterno le particelle virali appena formate.
Una simile struttura presenta, ad esempio, il Virus delle Ali Deformi, uno dei principali responsabili dei collassi delle colonie che si registrano a fine stagione nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta, ma anche Covid-19 è un virus a RNA a singolo filamento.
Diffusione
Molti virus delle api sono diffusi in tutto il mondo. La diffusione su larga scala dei virus è dovuta principalmente agli scambi di materiale biologico (ad esempio api regine e pacchi d’ape).
In effetti, abbiamo visto come un’epidemia scoppiata in Cina, sia diventata, nel giro di pochi mesi una vera e propria pandemia, con il Covid-19 che si è diffuso in tutti gli angoli del pianeta, proprio a causa degli spostamenti a lungo raggio di persone infette.
Nel caso del DWV, la diffusione su larga scala dipende anche dalla diffusione ubiquitaria del principale vettore di questo virus: l’acaro Varroa destructor.
Contagio
La trasmissione dei virus da un’ape infetta a un’ape sana può essere verticale, se avviene da una generazione a quella successiva (ad esempio quando un’ape regina infetta depone uova a loro volta infette), oppure orizzontale, se avviene tra individui della stessa generazione. In quest’ultimo caso, le particelle virali possono essere diffuse da vettori, come la Varroa nel caso del DWV, ma anche per via orale, mediante la trofallassi o attraverso le diverse matrici alimentari presenti nell’alveare (ad esempio miele, polline e pappa reale). Invece, negli alveari, la via di trasmissione aerea è praticamente assente, mentre è quella più comune nella diffusione dei virus dell’influenza e del Covid-19.
Nel caso delle api, la trasmissione verticale è piuttosto limitata, mentre quella orizzontale gioca un ruolo di primo piano.
Le vie di infezione nella colonia, dunque, sono molteplici, tant’è vero che, entro l’estate, il 100% delle api di ogni colonia è infettata da DWV (in gergo si dice che è “positiva” e questo stato si verifica né più né meno che con gli stessi metodi usati per analizzare i tamponi del Covid-19).
La diffusione del virus negli alveari è dunque rapida e inevitabile. Le api, infatti, sono insetti sociali e, come tali, vivono in colonie numerose, in cui gli individui stanno a stretto contatto tra loro; la condivisione del cibo, le cure che gli adulti riservano alla covata e le modalità di comunicazione delle api, che richiedono contatti ravvicinati, accelerano questo processo.
Inoltre, la colonia mantiene costanti temperatura e umidità relativa, a un livello che è particolarmente propizio per la proliferazione di molti patogeni e in particolare per la vita di parassiti, come la Varroa, che contribuiscono alla diffusione del virus.
In pratica, un alveare senza melari può ospitare circa 30000 individui in un volume pari a 0,5 m3; in uno spazio così ristretto, è impossibile evitare i contatti e quindi la diffusione del contagio a tutti gli individui. Per capirci, sarebbe come chiudere 30000 persone nello stadio Friuli in piena pandemia e sperare che il virus non si diffonda.
La socialità, dunque, è uno dei fattori chiave nella diffusione dei virus fra le api e, come abbiamo capito in questi giorni di isolamento forzato a cui siamo sottoposti, lo è anche fra le persone.
Quando si parla di api, però, bisogna considerare che i patogeni si possono trasmettere non solo all’interno dell’alveare ma anche tra alveari diversi.
Ad esempio, attraverso la sciamatura si può avere una trasmissione verticale del virus dalla colonia madre allo sciame, ma si può anche dare una trasmissione orizzontale, quando il virus passa da una colonia all’altra attraverso il saccheggio o la deriva.
Quindi, parassiti e patogeni si trasferiscono anche con facilità fra alveari diversi.
Per restare all’analogia con Covid-19, esso si è rapidamente propagato nella città di Wuhan, ma altrettanto velocemente ha raggiunto le città dei dintorni e del resto del mondo.
Sintomi
È stato detto che ben presto tutte le api di un alveare risultano positive al Virus delle Ali Deformi, anche nel caso in cui l’alveare sia trattato contro la Varroa. Tuttavia, la positività al virus non implica necessariamente uno stato patologico; infatti, il DWV può causare infezionilatenti, quando la replicazione del virus è contenuta e non si osservano evidenti segni clinici della virosi, e infezioniconclamate, quando le api e l’alveare mostrano chiaramente i sintomi della malattia. È in quest’ultimo caso che il virus diventa decisamente dannoso per le api.
Le infezioni restano allo stadio latente soprattutto perché il sistema immunitario dell’ape riesce a fronteggiare l’infezione virale e mantenerla sotto controllo.
Il passaggio dallo stato di latenza a un’infezione conclamata è caratterizzato dalla replicazione massiccia del virus, per cui il numero di particelle virali presenti all’interno di ogni ape aumenta anche di mille miliardi di volte.
Questo fenomeno può essere accentuato dalla presenza di stress di natura abiotica (ad esempio variazioni di temperatura, presenza di pesticidi o nutrizione inadeguata) o biotica, come l’azione del parassita V. destructor.
In particolare, è stato dimostrato come la Varroa oltre a trasmettere il virus da un’ape all’altra, ne stimola la riproduzione andando a interferire con le difese immunitaria dell’ape. Questo fenomeno è di fondamentale importanza, perché rende conto della dannosità di questo parassita, che altrimenti sarebbe meno micidiale per le api.
Purtroppo, il passaggio di un’infezione virale allo stadio conclamato è spesso repentino e causa rapidamente lo spopolamento e la morte della colonia.
Nel caso del Covid-19, sono stati individuati sintomi caratteristici, fra cui si ricordano la febbre, la tosse e le difficoltà respiratorie.
Tuttavia, non è detto che tali sintomi si manifestino in tutti gli individui positivi e molte persone contraggono l’infezione (diventando “positivi”) senza manifestare sintomi.
Rimedi
Purtroppo, contro i virus delle api non esistono rimedi terapeutici specifici, anche se sono allo studio dei prodotti per limitare l’impatto di alcuni virus mediante la tecnologia dell’interferenza a RNA (RNAi).
Tuttavia, nel caso del DWV, un controllo efficace di V. destructor, attraverso le tecniche note e i trattamenti acaricidi disponibili, è solitamente sufficiente per contenere la proliferazione del virus oltre i livelli letali per la colonia.
Inoltre, si può anche agire per mitigare gli effetti nocivi dell’infezione. In particolare, uno studio recente, condotto presso il Laboratorio di Apidologia e Apicoltura dell’Università degli Studi di Udine, ha dimostrato che l’assunzione di polline aumenta la sopravvivenza delle api infestate dalla Varroa, riducendo significativamente la carica dei virus (ad esempio DWV) a essa associati.
Analogamente, nel caso di Covid-19, i maggiori sforzi in questa prima fase sono stati concentrati sulla mitigazione degli effetti nocivi del virus attraverso la ventilazione forzata, per controbilanciare gli effetti della polmonite virale; di pari passo sono procedute le prove con varie sostanze a possibile azione terapeutica. Tuttavia, una soluzione duratura si potrà dare solamente quando verrà finalmente sviluppato un vaccino per rendere più tempestiva ed efficace la risposta anticorpale in caso di infezione.
Tornando alle api, occorre constatare che i vaccini presuppongono l’esistenza di una difesa specifica basata su anticorpi che purtroppo non è presente nelle api; dunque, è inutile attendersi un vaccino contro i virus delle api.
Di conseguenza, non resta che cercare di evitare il passaggio da infezioni latenti tendenzialmente benigne a devastanti infezioni conclamate, procurando di mantenere sotto controllo il principale vettore e attivatore del più importante virus delle api. Contemporaneamente, si dovrà agire per supportare le capacità intrinseche dell’ape di tollerare le infezioni virali con i vari mezzi a disposizione, tra cui un’alimentazione di qualità basata su miele e polline variegato e abbondante.
È compito dell’apicoltore (e dell’intera comunità) favorire il benessere di questi insetti, attraverso azioni mirate a salvaguardare l’ambiente, da cui le api (e gli uomini) traggono la gran parte delle risorse essenziali per alimentare il sistema immunitario e fronteggiare i problemi di natura sanitaria.
LAR, 15 maggio 2020